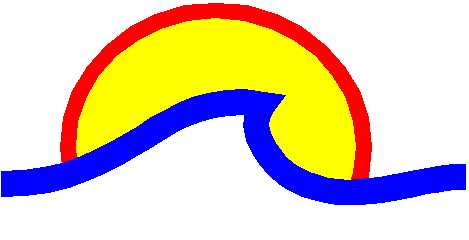The Tomb of Harwa, Egypt (TT37)
Active
Archeological SiteAttivita’ delle
Civiche
raccolte archeologiche
di
Milano nella Tomba of Harwa (tt 37)
Qurnah, November 8th, 1997Ottobre - Novembre 1997 La campagna archeologica delle Civiche Raccolte Archeologiche di Milano nella Tomba di Harwa (Tomba Tebana 37) è iniziata il 19 ottobre e ha avuto termine l’8 novembre 1997. Scopo principale era quello di proseguire il lavoro di restauro e ripulitura delle pareti della Seconda Sala Ipostila, cominciato l’anno passato, e di iniziare a rimuovere lo strato di detriti che ingombrano il pavimento della Prima Sala Ipostila.
La missione era composta
da: Francesco Tiradritti (direttore ed egittologo), Rosanna Pirelli (egittologa),
Ilaria Perticucci (restauratrice), Franco Lovera (fotografo), Sandro Senni
(Architetto) e Giacomo Tiradritti (amministratore).
Oltre al Dott. Mohammed
Soghair, direttore generale per le Antichità dell’Alto Egitto, tengo
qui ad esprimere un vivo ringraziamento al personale del Supreme Council
of Antiquities, Ispettorato di Qurna, nelle persone del Dott. Mohammed
Nasr (direttore generale), Dott. Mohammed el-Bialy (direttore) e Yasser
Yussef Ahmed (ispettore). Il loro aiuto e la loro assistenza si sono dimostrati
estremamente preziosi per il conseguimento di tutti i risultati ottenuti
nel corso della campagna di scavo 1997.
Qurna, 8 novembre 1997
Francesco Tiradritti
Civiche Raccolte Archeologiche
Via Luini, 2
I-20123 Milano
Search for Harwa
with eBlast and
Altavista
The Tomb of Harwa: www.harwa.com
Email me on: [email protected]
Archaeological
Activities
of
the
Museum
of Milano
in
the
Tomb
of Harwa (TT37)
Attivita’ archeologiche
All’inizio della campagna di scavo 1997 la Prima Sala ipostila risultava
uniformemente coperta da uno strato di detriti di altezza variabile tra
i trenta e gli ottanta centimetri. Si trattava soprattutto di frammenti
di calcare provenienti dal crollo del soffitto. Vi erano inoltre molti
blocchi con testi geroglifici provenienti dalle pareti e dalle due file
di pilastri che un tempo dividevano l’ambiente in tre navate.
Allo scopo di rilevare
la posizione di ogni ritrovamento, la sala è stata divisa in una
griglia virtuale data da quattro file di quadrati, ognuno dei quali ha
come punti fissi l’asse principale dell’ambiente e il centro dei pilastri
(vedi pianta I).
Lo scavo ha avuto inizio dalle sale secondarie che si aprono lungo il lato settentrionale e meridionale della sala stessa. Si è agito in tale maniera per creare una serie di spazi dove immagazzinare i frammenti di calcare decorati che venivano recuperati nel corso dei lavori. A questo scopo, nel corso della campagna 1996, erano già stati liberati gli ambienti S1, S2 e S5.
Vicino all’entrata
della camera sussidiaria S3 è stata scoperta una sepoltura disturbata
di cui facevano parte due vasetti, una coppetta (con resti di cibo all’interno)
e uno scarabeo in calcare di rozza fattura. Situazione analoga è
stata riscontrata anche nella camera S4 dove, associati ai resti di alcune
ossa, sono stati rinvenuti alcuni oggetti che sembrerebbero far parte di
una duplice sepoltura: due balsamari in vetro azzurro dal collo molto lungo
(uno parzialmente fuso), due vasi in terracotta identici (di uno restano
soltanto due frammenti), un balsamario in vetro ossidiano completamente
fuso e una lucerna del tipo “arms and frog” (fig. 1).

Fig. 1: Corredo
funerario ritrovato nella camera sussidiaria S4
|
||
Nella camera sussidiaria
N2 è stato rinvenuto un grande numero di frammenti di ceramica,
appartenenti a varie epoche della storia egiziana. Ciò induce a
ritenere che l’ambiente sia stato utilizzato come una sorta di discarica
per vasi rotti. Nell’angolo SE, a livello di pavimento, sono stati rinvenuti
una coppetta completa ed un balsamario in vetro trasparente, parzialmente
fuso. Potrebbe trattarsi dei resti di una sepoltura risalente ai primi
secoli della nostra era. La sua scoperta indurrebbe a datare i frammenti
di vaso che riempivano l’ambiente ad un’epoca posteriore. Tra questi è
degno di nota un coperchio (o un piattino utilizzato come tale) su cui
è tracciata ad inchiostro una linea di iscrizione ieratica che reca
una datazione (mese, stagione e giorno), forse riferita al momento confezionamento
del recipiente che coperchio tappava.
Numerosi ushabty in
terracotta di fattura molto rozza sono invece stati rinvenuti all’interno
e vicino all’entrata della camera N3. Nell’angolo SE dello stesso ambiente
è stato anche ritrovato un notevole numero di vaghi di reticella
per mummia in faïence. Questa evidenza induce a ritenere che la stanza
sussidiaria sia stata utilizzata come luogo di sepoltura tra la fine del
periodo faraonico e l’inizio di quello romano. Sempre nella camera N3,
sopra i detriti che ricoprivano il pavimento, sono venuti alla luce i resti
di un falso vaso canopo in calcare con coperchio a testa di babbuino (Hapi).Potrebbe
provenire dalla cavità irregolare che si apre al centro della parete
finale della sala sussidiaria e non è da escludere che sia da porre
in connessione con i resti di sepoltura qui rinvenuti (Fig. 2).
|
|
||
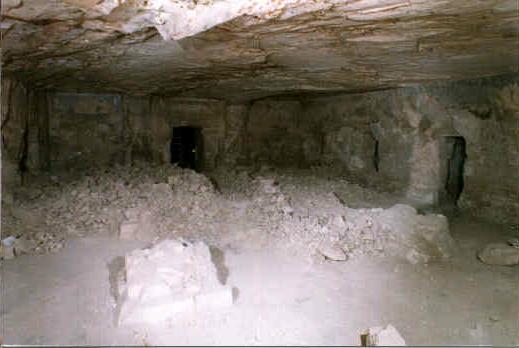
Fig. 2: Vaso canopo
con coperchio a testa di babbuino (Hapi)
|
||
|---|---|---|
Una volta svuotati
una parte degli ambienti sussidiari si è potuti passare allo scavo
della Prima Sala Ipostila. Per il momento, il settore più vicino
all’entrata è stato tralasciato, perché ingombro di frammenti
di iscrizioni e statue di notevoli dimensioni, provenienti da altri monumenti
delle necropoli tebane (tempio funerario di Mentuhotep II Nebpehetyra,
tomba di Pabasa) e qui depositati dal Servizio delle Antichità egiziano
al fine di preservarli dai furti. I lavori nella Prima Sala Ipostila sono
proseguiti fino al completo sgombero della parte centrale della stessa.
(Fig. 3).

Fig. 3: La Prima Sala
Ipostila in una fase avanzata dello scavo
|
||
|---|---|---|
Nella navata settentrionale
è stato posto in luce un crollo che aveva interessato un’ampia porzione
del soffitto. Alcuni frammenti di calcare recano ancora tracce della decorazione,
costituita da strisce rosse su sfondo dipinto in un azzurro di due tonalità
diverse. I pezzi scoperti non sono però sufficienti per comprendere
il disegno complessivo.
Anche la decorazione
delle pareti e dei pilastri era dipinta in blu e in rosso. Nella navata
meridionale della sala sono stati ritrovati molti frammenti delle scene
soprastanti gli ingressi delle stanze sussidiare S2, S3 e S4. E’ stato
così possibile ricostruire una grande tavola per offerta (S2), una
scena di macelleria (S3, Fig. 4) e una teoria di portatori di offerta (S4).
Quest’ultima trova un preciso riscontro con la decorazione della stanza
sussidiaria che si apre sul lato opposto (S4). Nonostante le scene che
abbellivano la parete settentrionale siano andate perdute, nessun frammento
ad esse riferibili è stato finora rinvenuto. Questo sarebbe da imputare
allo stato di migliore conservazione di questa parte della Prima Sala Ipostila
rispetto a quella meridionale. La parete settentrionale, rimasta pressoché
intatta fino ad un’epoca abbastanza recente, avrebbe sofferto dei danni
provocati dai cercatori di antichità nel secolo scorso.
Su alcuni frammenti
di pilastri sono state scoperte le figure delle personificazioni femminili
delle Ore del Giorno e della Notte e di alcune divinità maschili.
Tra queste (da identificare con i demoni-guardiani della Ore), una a testa
di ariete si ripete sui pilastri sia della fila settentrionale (Fig. 5)
sia di quella meridionale.
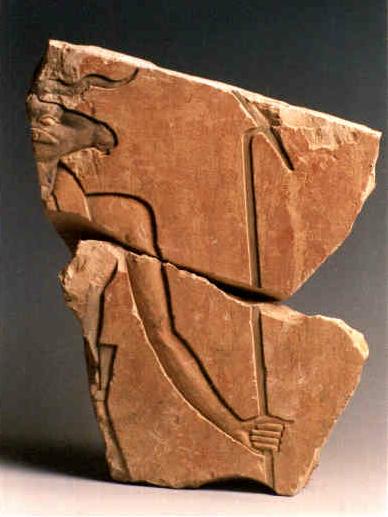
Fig. 4: Parte della scena di macelleria che decorava l’entrata all’ambiente S3 |
||
|---|---|---|
Su alcuni frammenti
di pilastri sono state scoperte le figure delle personificazioni femminili
delle Ore del Giorno e della Notte e di alcune divinità maschili.
Tra queste (da identificare con i demoni-guardiani della Ore), una a testa
di ariete si ripete sui pilastri sia della fila settentrionale (Fig. 5)
sia di quella meridionale.
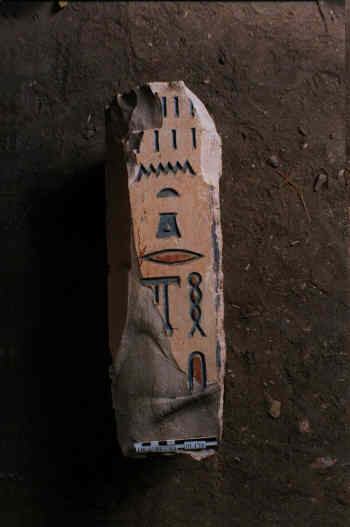
Fig. 5: Divinità a testa di ariete dalla decorazione dei pilastri meridionali. |
||
|---|---|---|
Testi geroglifici menzionanti
la VII, la IX (Fig. 6) e la XII Ore della Notte sono venuti alla luce in
corrispondenza dei resti dei pilastri meridionali. I dati forniti dal rilevamento
dell’esatto luogo di ritrovamento di ogni frammento sembrerebbero indicare
che il testo si sviluppava da ovest ad est. Questa particolare disposizione
consente di ipotizzare che le iscrizioni siano state trascritte sui pilastri
in modo da seguire il cammino del sole nell’Oltretomba, dove l’astro sorge
ad ovest e tramonta ad est.

Fig. 6: Frammento di pilastro con la menzione alla IX Ora della Notte |
||
|---|---|---|
Nella navata settentrionale
della Prima Sala Ipostila è stata rilevata una situazione archeologicamente
ben stratificata. Le ampie lastre di calcare del soffitto ricoprivano,
sigillandolo, uno strato di resti umani, poveramente conservati, misti
a calce. Tale situazione testimonia un periodo di epidemia, la cui datazione
è estremamente difficile, data l’assenza di qualsiasi oggetto di
corredo. Le tracce di questa epidemia sono già state rilevate altrove
nella necropoli tebana. Al di sotto di questo strato, a livello di pavimento,
sono stati scoperti i resti di sepolture con poveri corredi funerari. Il
gruppo di oggetti conservatosi in migliore condizioni (probabilmente da
considerarsi intatto) è stato rinvenuto nell’angolo NE del Quadrato
I.D2. Quattro vasi in ceramica, un balsamario in vetro trasparente e uno
in vetro ossidiano sono stati rinvenuti in associazione ad uno scheletro
assai disturbato, con la testa rivolta a ovest (Fig. 7).

Fig. 7: Corredo funerario di epoca romana dal quadrato I.D2 |
||
|---|---|---|
A non molta distanza
da questa sepoltura, sempre a livello di pavimento, sono state rinvenute
le tracce di un fuoco. Mancando qualsiasi connessione con ciò che
lo circonda è assai difficile stabilire da chi e in che momento
della storia della tomba sia stato acceso. Il fatto che all’interno dei
carboni vi fossero frammenti di ceramica potrebbe indicare che il fuoco
risalga ad un periodo abbastanza tardo della frequentazione della tomba
e sia forse da connettere proprio con le inumazioni effettuate in periodo
di pestilenza.
In prossimità
dell’entrata, quasi a livello superficiale, è stato ritrovato il
frammento centrale di un ushabty in pietra scura (forse basalto) di Harwa.
La parte superiore di un secondo ushabty, in pietra verde, è stata
invece scoperta al centro della sala, ad un’altezza di cm 30-40 dal livello
del suolo (Fig. 8). Una volta ripulito dalle incrostazioni di calcare che
lo ricoprivano quasi per intero, quest’ultima ha rivelato una fattura estremamente
accurata. Pur iscrivendosi nello stile tipico della XXV dinastia, il viso
dell’ushabty mostra caratteristiche che consentono di ricondurlo all’ambito
della statuaria regale del periodo a cavallo tra la fine della IV e l’inizio
della V dinastia.
Un ushabty in calcare
di Harwa, pressoché completo (anche se spezzato) è stato
scoperto a non molta distanza dal precedente (Fig. 9). La sua fattura è
eccellente ed è sorprendente il fatto che stringa nelle mani, invece
degli abituali strumenti per il lavoro nei campi, il flagello e lo scettro,
normalmente utilizzati per designare l’autorità faraonica. Anche
il titolo che compare nell’iscrizione (wr wr.w, “il grande dei grandi”)
sembrerebbe indicare che, in questa statuetta, si è voluto attribuire
ad Harwa maggiori poteri di quanto lasci supporre la sua funzione di Grande
Maggiordomo della Divina Adoratrice.

Fig. 8: Frammento superiore di ushabty in basalto di Harwa (prima del restauro) |
||
|---|---|---|
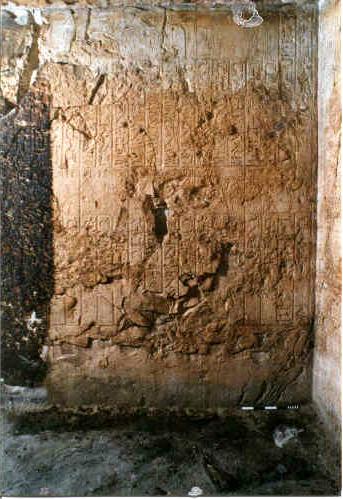
Fig. 9: Ushabty in calcare di Harwa |
||
|---|---|---|
Il fatto che tutti gli ushabty di Harwa ritrovati all’interno della sua tomba (nel corso della presente campagna di scavo e della precedente) giacessero lungo il percorso assiale del monumento e ad una certa altezza dal livello del suolo potrebbe confermare l’ipotesi formulata in passato da J.J. Clère (BIFAO 34, 1934). Sulla base del ritrovamento di alcuni ushabty tra i rifiuti che colmavano il lago sacro di Medamud (località a circa km 15 a nord di Luxor), Clère afferma che gli ushabty di Harwa sarebbero stati prelevati dalla sua tomba in periodo tardoantico.
Uno scavo di salvataggio
è stato condotto anche lungo la sommità del lato meridionale
del cortile della tomba. Qui si era sviluppato un fronte di frana che,
con le piogge torrenziali del 1994 aveva condotto alla formazione di un
cono di detriti di notevole entità all’interno dello stesso cortile.
Al fine di evitare il ripetersi di un tale fenomeno, il terreno soprastante
è stato lievemente terrazzato. Nel corso di questo scavo è
stata riportata alla luce una porzione della sommità del muro in
mattoni crudi della rampa di accesso al tempio funerario di Mentuhotep
II Nebpehetyra.

Fig. 10: La parete occidentale della Seconda Sala Ipostila dopo il restauro |
||
|---|---|---|
Attivita’ di restauro
Il metodo di pulizia delle pareti messo a punto nel corso della campagna
1996 dalla restauratrice Ilaria Perticucci si è dimostrato di estrema
efficacia e semplicità. È stato così possibile insegnarlo
ad un restauratore, messo a nostra disposizione dal Supreme Council of
Antiquities, e ad alcuni operai egiziani. È stato così possibile
creare una squadra di operai specializzati che potrà proseguire
la rimozione del guano di pipistrello dalle pareti della tomba con una
certa continuità negli anni a venire.
La velocità
del lavoro di restauro è così notevolmente aumentata. Nel
corso di questa campagna è stata ripulita la maggior parte della
parete occidentale e una larga porzione di quella meridionale della Seconda
Sala Ipostila (Fig. 10). In quest’ultima zona, l’azione del restauro si
è dimostrata particolarmente efficace. A mezza altezza, la completa
rimozione del guano ha infatti condotto alla scoperta di una fila di vignette
con scene relative al rituale di purificazione della mummia. Sono identiche
a quella che decorano la sommità della parete e, coperte come erano
dal guano, non erano mai state notate finora (Fig. 11)
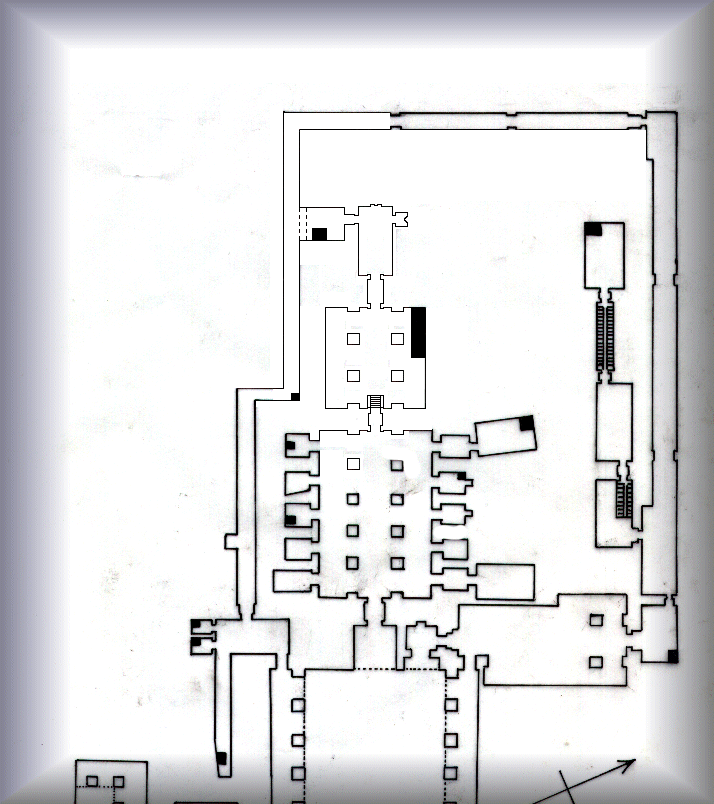 |
||
|---|---|---|